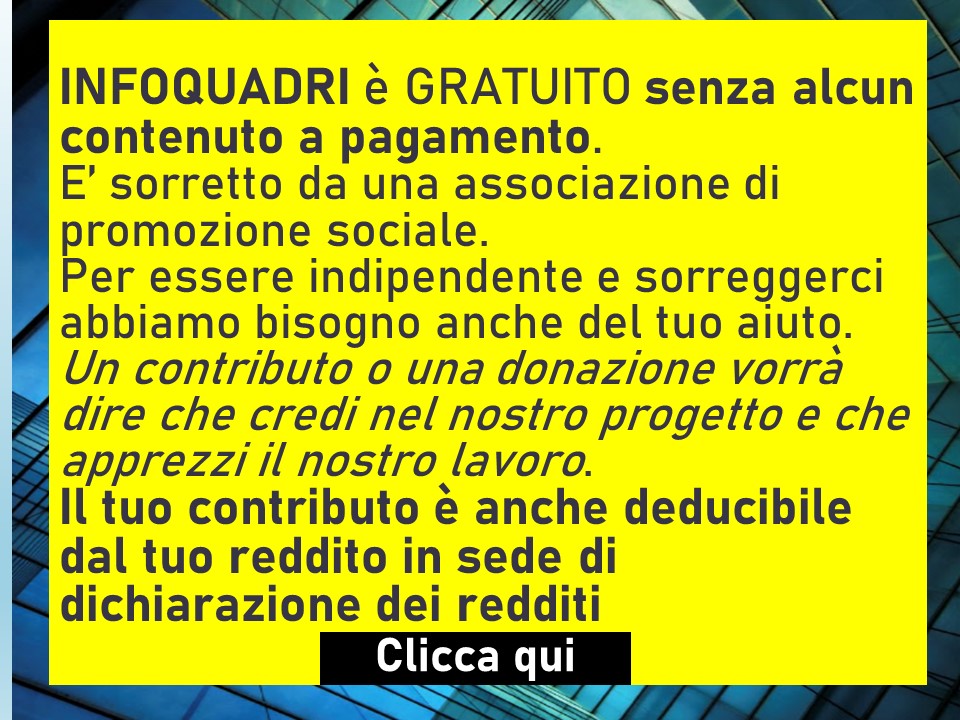Siamo davvero pronti a gestire lo smart working?

Benvenuti nell’era del “lavoro senza posto di lavoro”, lo smart working, la modalità di lavoro prevalente adesso in Italia nel settore privato. Un fenomeno che costituisce la punta dell’iceberg del più ampio ghiacciaio dell’innovazione tecnologica e digitale, destinato a cambiare il lavoro, i suoi processi e i suoi contenuti. I giovani neoassunti chiedono di non avere neanche un giorno in presenza, le aziende per attingere ai migliori ormai promettono “a casa sempre” e chiudono sedi ormai vuote, smontano processi di governo dell’impresa basati sul controllo fisico, accelerano nella smaterializzazione di tutte le procedure. I comparti da subito coinvolti in questa corsa alla “vita senza sede di lavoro” sono quello delle aziende informatiche e di servizi, ma anche banche e assicurazioni, li dove il rapporto con il pubblico è molto labile ed il cliente è molto spesso una entità che può essere connessa. La pandemia da Covid-19 ha innescato una forte accelerazione, costringendo, da due anni a questa parte, anche i fautori del posto fisico di lavoro, della separazione tra casa e lavoro perché necessario per una produttività, impensabile fino a due anni fa in forme diverse, deve ora fare i conti con nuove modalità, rendendo più pervasivo l’impatto delle tecnologie sulle mansioni svolte. Molti ormai sono pagati per stare a casa, non venire mai in sede, essere iperconnessi e fare affidamento alle proprie forze dove il team è si sempre disponibile ma solo via chat, webcam, webroom. Secondo le previsioni dell’Osservatorio sullo smart wornking del Politecnico di Milano, quasi 4,5 milioni di lavoratori (su un totale di circa 22 milioni di occupati) continueranno dopo la pandemia ad operare, almeno in parte, da remoto: si tratta di 2 milioni di dipendenti delle grandi imprese, 700 mila delle pmi, poco meno di un milione nelle microimprese e altri 680mila nella pubblica amministrazione. E i sindacati, che pure avevano qualche perplessità, hanno favorito questa trasformazione che in genere è ben vista dai lavoratori interessati. Siamo dunque di fronte a un cambio di prospettiva che spinge le aziende a rivedere i loro modelli gestionali con l’obiettivo di migliorare, insieme al work-life balance dei dipendenti, anche la produttività del lavoro. In effetti, sempre secondo i dati dell’Osservatorio, prevale oggi uno smart working con modalità ‘ibride’, ovvero con un’alternanza tra lavoro in sede e a distanza. Nelle grandi imprese in media non si va in ufficio 2 e spesso 3 giorni a settimana. In taluni casi la scansione è mensile. L’indagine della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, in collaborazione con Swg riporta uno scenario di profondo cambiamento con il 61% degli intervistati che afferma che, negli ultimi anni, la rivoluzione tecnologica ha cambiato il proprio modo di lavorare, nel 18,1% dei casi, “in modo sostanziale”. Per la maggioranza (54,9%), recita lo studio dei professionisti l’impatto è stato positivo, riducendo i tempi e rendendo più semplici alcune attività (42,4%), favorendo una migliore organizzazione (34,3%), facilitando le relazioni con pubblico, utenti, clienti e fornitori (20,5%), sostituendo attività ’routinarie’ e ripetitive (17,2%) e creando nuove opportunità (15,2%)». Tutto bene quindi? Niente affatto. Gli psicologi del lavoro iniziano a porsi alcune domande, la prima è l’ampio margine di discrezione dato allo smart worker: fai tu, lavora tu dove ti pare, nei tempi che vuoi…. Una libertà che crea problemi, di identità, di spazio privato contro pubblico, di solitudine che attanaglia tanti smart worker. Il risultato è che si perde ogni ritmo di lavoro, non ci sono riferimenti tranne il bimbo che chiama, il sugo da girare, il continuo trillare dei messaggi. Sul posto di lavoro nascono amicizie, si conosce gente, si cattura un informazione non scritta, avvengono scambi passaggi in auto, c’è confronto, si apprende qualcosa: relazionarsi. Lo smart worker non può farlo. Il boom dei co-working, di quelle caffetterie che si prestano al lavoro agile, dimostra che c’è chi a casa proprio non si sente a suo agio a lavorare (sono cresciute del 76% nell’ultimo anno). C’è il tema delicatissimo di orari e abitudini cementificate da tante ore di solitudine sulle spalle, è difficile distaccarsene, lo stesso vale per gli altri.
Nel 2021 gli stessi lavoratori costretti a casa fornivano un giudizio ambivalente, evidenziando le criticità connesse al lavoro da remoto, nel 2022 ben l’84,2% degli addetti “agili” promuove a pieni voti questo modello, perché «concilia lavoro e vita privata». Ora «il 31,8% degli italiani non accetterebbe di tornare a lavorare in presenza, il 16,9% cambierebbe lavoro e il 9,3% potrebbe addirittura licenziarsi». La ricerca dei consulenti del lavoro apre ad una domanda: siamo sicuri che tutto questo smart working faccia bene alla produttività delle aziende italiane?